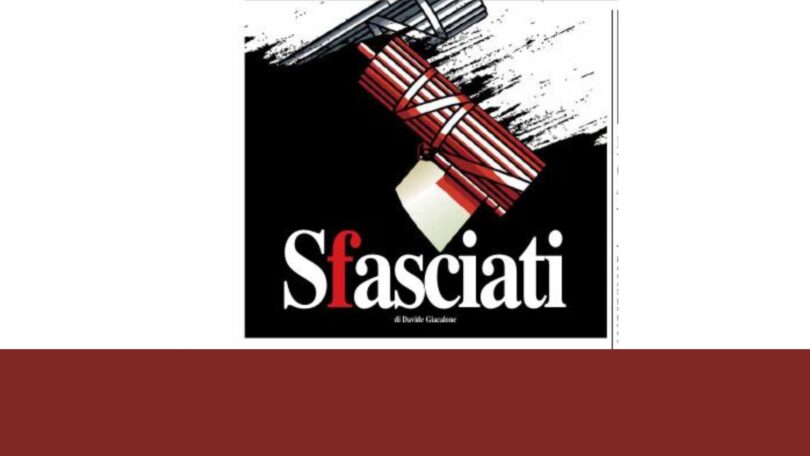Nel festival della retorica c’è anche questo: i parlamentari che hanno votato a favore della separazione delle carriere e poi firmano per il referendum che può cancellarla. Dicono di volere che siano gli italiani a decidere, così argomentando la loro inutilità funzionale. In compenso a raccogliere le firme, sperando di cancellare la riforma, sono quelli che la sostennero per lustri. Avvalorando l’inutilità di starli a sentire.
Suppongo che già la settimana prossima cominci a scemare l’attenzione, anche perché cinque o sei mesi di preliminari diventano una sfida che sfocia nel mistico. Si passerà alla finanziaria, destinata a essere approvata quando le palle si troveranno anche sugli alberi. Prima di sapere come andrà a finire sarà bene farsi un’idea di come è andata a cominciare, perché nella risposta alla seguente domanda c’è tutto l’universo della politica italiana: la riforma voluta dalla destra è di destra?
La risposta è No, anzi è una riforma che sfascia l’Italia, nel senso che la allontana dal fascio. Tanto non è (di suo) di destra che giusto ieri la sinistra (Pd e M5S) votava la legge Cartabia – che almeno limitava a uno i cambi di funzione – e Fratelli d’Italia votava contro. La sola coerenza, consistente nel dire l’uno il contrario dell’altro. Da quarant’anni si litigano il ruolo di servitori non della giustizia (magari!) ma delle Procure, dello spettacolo dell’accusa, ergo litigandosi il giustizialismo.
La risposta è No per un motivo decisamente più alto, che viaggia sopra il parapiglia. Nel 1987 l’Italia si diede un nuovo Codice di procedura penale, redatto a cura della migliore cultura giuridica e patrocinato da un ministro eroe della Resistenza, Giuliano Vassalli. Quel codice sostituiva quello che portava il nome di un giurista (con i fiocchi) fascista: Alfredo Rocco. Segnalo mestamente che il Codice penale firmato dal re e dal duce è ancora vigente e neanche troppo rimaneggiato.
L’autentica rivoluzione liberale sta nella concezione di quella nuova procedura, che a giusta ragione soppianta il costrutto opposto del fascismo. Nel codice fascista giudicanti e requirenti incarnavano, allo stesso tempo, la pretesa punitiva dello Stato e la capacità dello Stato di giudicare i propri cittadini. Non poteva che essere così, perché l’etica era incarnata dallo Stato stesso. E non poteva che essere così anche nelle dittature rosse, perché i bastardelli di Hegel quello credono: che l’etica sia nello Stato.
La rivoluzione del codice accusatorio si basa su un principio opposto: nessuno ha il metro dell’etica, la chiarezza discende solo dallo scontro fra le parti – l’accusa e la difesa – e la prova non si forma negli uffici dei togati statali ma nell’aula del tribunale. Il principio di quel codice è eminentemente liberale perché esclude che ci sia una mente o mano pubblica che conosca il vero e il giusto interesse collettivo, ma s’affida al conflitto fra interessi acciocché si addivenga a una qualche conclusione ragionevole. Motivo per cui nulla di tutto questo può funzionare se le due parti non si trovano su un piano identico e se una delle parti – ovvero l’accusa – si ritrova collega di chi giudica. Non è un granello nell’ingranaggio, ma un treno contro una montagna.
Ecco perché i magistrati cultori della percentuale minuscola, quelli che dicono che la legge Cartabia basta (dopo essersi opposti alla medesima, tanto qui si dimentica tutto) si sbagliano: negare quel presupposto culturale significa tornare alla matrice del codice fascista, ispirato allo Stato etico.
Noioso? Può darsi, ma meno dei trasformisti in servizio permanente effettivo. Se volete sollazzarvi c’è sempre l’inquisizione milanese, quella che manda in galera le persone per poi scoprire che manco l’accusatore di ultima istanza trova nell’inchiesta nulla su cui basare l’accusa. Con tanti saluti a quella “cultura della giurisdizione” che farebbe ragionare gli accusatori come fossero giudici. Che se fosse vero, quindi anche il contrario, sarebbe una buona ragione per darsela a gambe.
Davide Giacalone, La Ragione 8 novembre 2025