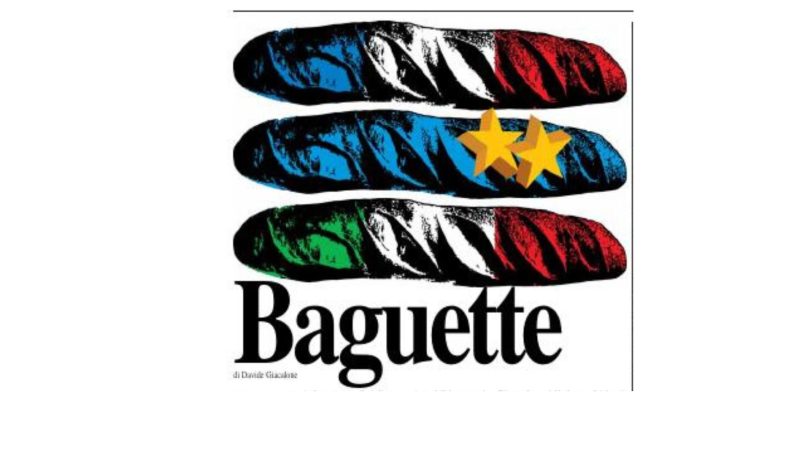La storia francese e quella italiana sono indissolubilmente intrecciate. Alcune pagine sono splendide, molte sono belle, talune imbarazzanti. Abbiamo molti interessi in comune, come anche – da ambo le parti – pregiudizi ottusi. Oggi ci inquietano Stellantis e debiti pubblici troppo alti. Ci unisce anche il ribaltamento di un luogo comune: la Francia vive l’instabilità governativa, mentre l’Italia la sua litigiosa stabilità. Molti avrebbero scommesso sul contrario.
La stabilità di un sistema politico, quindi anche di un governo, non è data (soltanto) dal modello istituzionale, ma dagli umori degli elettori e dalla condotta delle forze politiche. Certo, ci sono modelli scombiccherati in partenza – come sarebbe il premierato nella versione fin qui all’attenzione del Parlamento italiano – ma non esiste un modello che sia stabile o instabile in sé.
La Francia era additata a esempio di modello stabile: con il semipresidenzialismo il popolo elegge direttamente il presidente e con il doppio turno (di cui ero e resto estimatore) si concilia la scelta proporzionale con la designazione maggioritaria dei parlamentari. Da noi, fino al 1994, si è andati avanti con la centralità del Parlamento, nessuna elezione diretta e il sistema proporzionale (benché corretto). E ci siamo sorbiti decenni di superficialità sulla presunta instabilità italiana. Se anziché tenere il conto dei governi lo si tiene dei presidenti del Consiglio e dei ministri, si scopre che c’era più stabilità che altrove e che, comunque, in mezzo secolo le formule sono state soltanto quattro (centrismo, centrosinistra, solidarietà nazionale e pentapartito) e il governo non ha mai perso le elezioni. Poi, dal 1994, si è scimmiottato un falso maggioritario bipolare e il governo non le ha mai vinte.
In Francia, oggi, si vede che se gli elettori premiano le estreme – come sono liberi di fare – il doppio turno non le taglia, mentre la stabilità dell’Eliseo non si traduce in stabilità governativa. Ciò accade perché le forze politiche più forti tirano verso il conflitto piuttosto che verso la mediazione e, come non bastasse, provano a demolire il potere del presidente della Repubblica. Non c’è modello che possa cancellare una tale condotta. E se ne deve chiedere conto agli elettori. Tanto più che l’instabilità costa. I francesi hanno scoperto con orrore che lo spread può salire e superare quello della Grecia. Hanno un debito al 110% del Pil e uno spread che balla intorno agli 85 punti. Noi abbiamo un debito che veleggia a quota 140% e uno spread attorno ai 120, ma nessuno si scalda.
Il compito di mettere ordine nei conti nazionali è dei rispettivi governi, ma il problema dell’Unione europea è che non si possono fare cose che renderebbero pericolosi gli squilibri. Ecco perché una sana politica di crescita e sviluppo non solo si approvvigiona di debito comune, ma lo valorizza con politiche e scelte comuni. Cedendo sovranità. Altrimenti ciascuno sarà padrone del proprio sbilancio. E sai che soddisfazione. Il che ci porta a Stellantis.
Se governi alle prese con il consenso e il collasso delle fabbriche devono provvedere in proprio, sapranno parlare soltanto di «salvare i posti di lavoro». Che sembra bello, ma non significa niente e rischia anche di distruggerli. Se si usa il denaro dei contribuenti per tamponare, poi si generano bidoni e non si cresce. Si tengano l’Arna e la Fiat come esempi preclari di soldi pubblici buttati. Non si tratta di farne un tema ideologico, ma di rendersi conto che la dimensione competitiva è europea e di quella si deve ragionare compiendo le scelte che Stellantis ha rimandato, remunerando gli azionisti e depauperando il prodotto. O sei privato e fai quello che ti pare, ma poi chiudi, o ci sono aiuti pubblici, ma anche politiche pubbliche e blocco della remunerazione degli azionisti.
Francia, Italia, Ue e tutti gli altri abbiamo problemi – e forze – comuni. Il dilemma non è nella francese baguette o nell’italiana rosetta, bensì in quello che sapremo, assieme, metterci dentro.
Davide Giacalone
Pubblicato da La Ragione